di Mafalda Giuliano
Essere Educatori senza Frontiere è formazione, cammino e un viaggio di cui non scegli la destinazione. Essere educatore per me quest’anno è stato capire chi fossi agli occhi di bambini a cui non viene naturale avvicinarsi e che vivono ai margini della città di Roma, nel campo rom di Castel Romano.
Sapevamo che si trattava di un progetto pilota – della nostra prima collaborazione con una realtà sterminata come quella del Sant’Egidio – e che avremo mosso i primi passi in una realtà nuova, una scuola estiva per gli ultimi fra gli ultimi. Niente di più.
Prima di partire mi chiedevo se la nostra fosse presunzione, se il nostro concetto di educazione non si scontrasse con la forte ideologia dei gruppi rom, con quello che è stato definito un “popolo-resistenza”. Una volta arrivata lì, però, ho deciso di smettere di farmi domande. Ho semplicemente osservato, ascoltato e accettato.
Per i Rom noi siamo i gagé.
La prima e unica volta che ho sentito questa parola è stato da una volontaria del Sant’Egidio, lei ce lo ha tradotto come “non uomini”. Certo, se nella lingua romanì Rom significa “uomo”, il contrario ci potrebbe anche stare. Per esattezza però il termine gagé indica il non essere Rom: i gagè, quindi, sono “gli altri” per definizione, il resto del mondo. Noi eravamo “gli altri”.
Siamo persone diverse a seconda degli occhi di chi ci guarda, siamo quello che gli altri vogliono vedere in noi, siamo sempre altro finché qualcuno non ci vede. In quella periferia romana, quest’estate, abbiamo visto e ci siamo fatti vedere. È sparita la linea di demarcazione che ci voleva diversi, sono spariti gli aggettivi e le negazioni e siamo stati “noi”. Noi con i bambini, noi con gli anziani, noi con tutte le persone che abbiamo incontrato. Con chi non ha niente, con chi è solo, con chi è malato e con chi fa di tutto per rattoppare la rete dell’umanità.
Il senso a questo progetto lo abbiamo dato insieme, dal nostro piccolo e forte gruppo a quelli più grandi e sempre più invincibili che abbiamo saputo creare giorno per giorno. Siamo state brave e abbiamo incontrato persone speciali, forse per quelle leggi di attrazione che in EsF si svelano a ogni incontro.
Per i Rom bosniaci l’Italia è “il Paese dei campi”, intendendo i campi nomadi, recintati. Siamo andati lì per far vedere loro che siamo anche altro.
Siamo andati lì per tanti motivi, primo fra tutti far sì che i bambini entrassero in classe a settembre e non sentissero troppo il divario con i loro compagni. Siamo stati con loro e abbiamo sentito come quello fosse l’ultimo dei problemi, non per questo meno importante. E penso a quel pomeriggio caldo, caldissimo. C’era un’altalena e Diego ci volava sopra da un bel po’, poi ha detto quella cosa. Diego ha dieci anni, per Diego quella cosa era normale. Ho sentito freddo, freddissimo. All’improvviso Diego aveva mille anni, poi ha chiesto un bacio sulle labbra. Sono stata attenta, gli ho dato un bacio da bambini, non ho risposto alle sue parole. Non avrò mai parole per quegli abissi ma ho imparato a stare attenta. Attenta a non schivare le loro lame. Ci hanno insegnato la lingua che hanno dovuto apprendere, una lingua difficile e dolorosa. Noi l’abbiamo ascoltata. L’abbiamo amata a fatica. Abbiamo sentito il gelo sotto il sole d’agosto.
Ma quando siamo partiti non ci sentivamo più gagé.

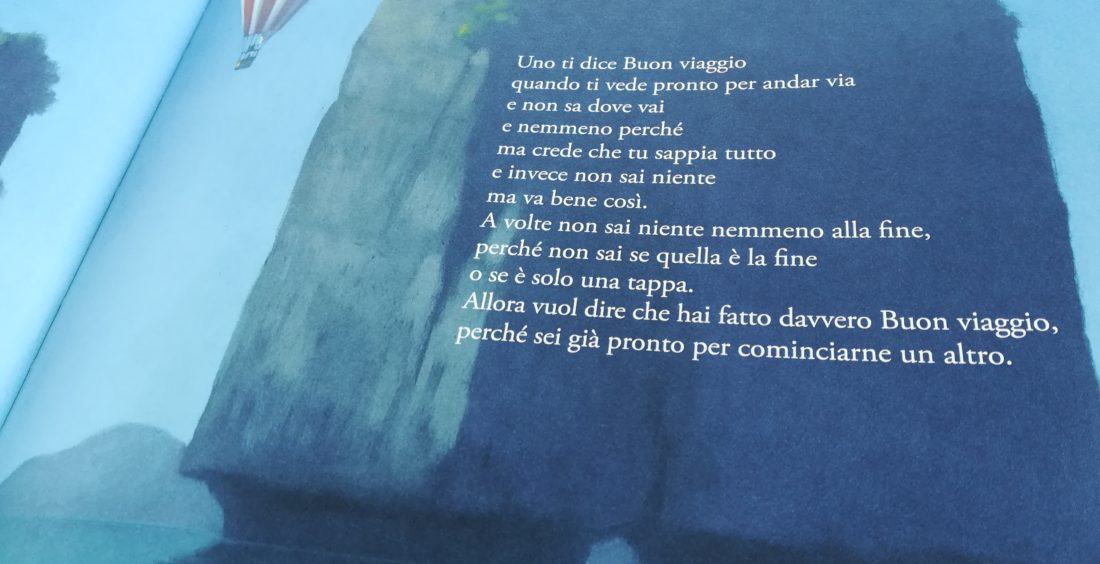

No comments yet.